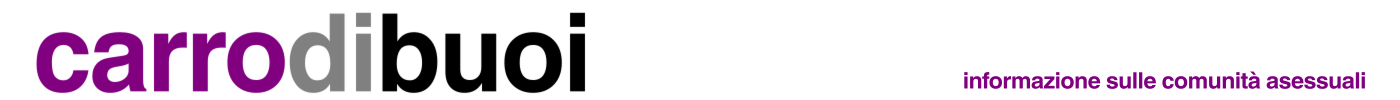Ma lo psicologo, lo sa di cosa parliamo?
Secondo quanto emerge da un articolo pubblicato sulla comunità on line bustle.com, le persone facenti parte della comunità LGBTQIA hanno il triplo di possibilità di avere un problema di carattere psicologico, secondo la National Alliance on Mental Illness, ed il tasso di suicidio dei giovani risulterebbe essere il triplo rispetto ai dati dei pari età cis-etero.
Un problema base sembra essere la difficoltà dell’ambiente professionale ad una maggiore fluidità da parte dei più giovani, che, a loro volta, preferiscono rivolgersi a terapie alternative, anziché attendere che i “vecchi” psicologi capiscano che, nel frattempo, è cambiato il mondo.
L’accettazione verso la comunità LGBTQIA è, almeno negli USA, in costante aumento. Ma le vecchie generazioni, che sono cresciute con un’altra idea di orientamenti sessuali e identità di genere, fanno fatica a stare al passo. Questo capita anche nella comunità medica, dove molti psicologi, per quanto in prima fila nel considerare la vita delle persone dal punto di vista più progressista possibile, abbiano posizioni un po’ antiquate in materia, e considerino l’identità o l’orientamento rivelato loro da alcuni millennials, come “una fase”, quando non addirittura “una moda”.
Altre volte, invece, i medici vanno in senso opposto, focalizzandosi troppo sull’orientamento della persona che hanno davanti, e cercando di spiegare con esso tutto ciò che capita al paziente, quando, invece, la ragione dei suoi problemi potrebbe essere altrove.
Molti psicologi più “anziani”, ad esempio, ignorano del tutto, o sottovalutano pericolosamente, alcune delle etichette che sono emerse negli ultimi anni, come pansessuali, aromantici, asessuali. Per cui riescono a gestire bene una persona che sia gay o lesbica, ma il rischio è che possano spingere, in qualche modo, ad una riduzione del caso che hanno davanti ad essere essenzialmente omo o eterosessuale.
Una soluzione, come fa notare un articolo di Clinical Psychology: Science and Practice, sarebbe quella di far integrare ai professionisti le conoscenze in ambito LGBTQIA ben prima di avere a che fare con i pazienti, anziché, come viene fatto adesso, al momento di prendere in carico un caso.
Anche in questo caso, comunque, si va incontro al solito problema: a tenere i corsi saranno psicologi più anziani che non hanno mai sentito parlare di asessuali, pansessuali, eccetera.
(Nota dell’autore: ignoro quale sia la procedura seguita in materia in Italia. Ogni contributo è gradito).
Per quello che sappiamo, nella comunità asessuale italiana, la situazione non è certo più rosea. Prosegue la medicalizzazione dell’asessualità, si prosegue a considerare il nostro orientamento come un blocco da rimuovere, per quanto gli incontri (come quello che si è tenuto a Bologna lo scorso 6 maggio), che ci auguriamo possano moltiplicarsi nei prossimi mesi, tra la comunità medico-scientifica e la comunità asessuale, siano occasioni eccellenti per risurre le distanze, permettere un lavoro migliore ai professionisti del settore, ed al tempo stesso evitare delle vere e proprie “torture” alle persone asessuali, soprattutto se giovani.
Probabilmente è giunto il momento che, anche da parte degli psicologi, si smetta di considerare l’asessualità come la cosa strana che è stata considerata fino ad ora, e si inizi a pensarla come una possibilità come un’altra.